
In questo studio analizzeremo la storia dell’anatomia umana da un punto di vista semiologico. Partiamo infatti dalla considerazione che il corpo umano si esprima nel linguaggio della bio-chimica e della fisiopatologia come un grande organismo comunicante. Ci sono voluti secoli per arrivare alle conoscenze che abbiamo oggi di anatomia, ma la sua stessa storia è significativa e interessante.
Il primo documento anatomico propriamente detto è un papiro egizio del 1600 a.C., esso rivela la conoscenza, da parte degli scienziati del tempo, della struttura dei visceri, ma non della loro funzione.
Nel mondo greco del V e IV secolo a.C. si raggiunse una maggiore e più precisa conoscenza grazie a figure come Alcmeone da Crotone (VI-V secolo a.C.), Ippocrate (460-377 a.C. secolo) e Aristotele (384/383-322 a.C.).
Tuttavia, il primo progresso che conferì all’anatomia umana il rigore di una disciplina scientifica venne compiuto nel secolo seguente dai medici greci Erofilo ed Erasistrato che, sezionando cadaveri, furono i primi a distinguere molte funzioni, tra cui quelle del sistema nervoso e dell’apparato muscolare. Gli antichi romani e gli arabi compirono scarsi progressi in questo campo.
A partire dal VII secolo a. C., l’interesse degli artisti greci per l’anatomia appare con maggiore evidenza nel campo della scultura. Nell’VIII secolo la figura umana viene ancora rappresentata sotto l’aspetto di profili schematici. Ma poi, a Corinto e nell’Attica, le proporzioni dei corpi diventano verosimili. I volumi muscolari sono indicati con esattezza. I dettagli anatomici (polpacci, caviglie, ginocchia, muscoli pettorali e addominali) vengono precisati con tratti incisi nella vernice nera.
Nel VI secolo l’eleganza decorativa si unisce al rigore dell’osservazione delle forme viventi e alla descrizione dei movimenti più complessi. Le opere di Exechia segnano, in questo stile detto delle “figure nere“, il momento di massima tensione e raffinatezza. Il passaggio allo stile delle “figure rosse” consentirà ai pittori di indicare i dettagli interni dei corpi nudi con pennellate e non più con linee incise. La maggior libertà che ne deriva consentì loro di raffigurare i muscoli con finezza e precisione.
Le pitture di Eutimide, di Olto e soprattutto di Eufronio confermano uno spiccato interesse per l’anatomia. Nel corso del V secolo quest’attenzione analitica comporta, spesso, una certa secchezza; la fattura è più rapida e libera. Roma e il suo impero adotterà i modelli greci senza sostanziali innovazioni. Le origini dell’anatomia antica, concepita come scienza, sono però difficili da precisare. È probabile che Ippocrate abbia sezionato cadaveri ma, all’epoca di Aristotele, le conoscenze teoriche di anatomia erano ancora limitate. È confermato invece che le prime dissezioni, e il progresso della medicina, sono legate alle ricerche della scuola di Alessandria.
Galeno: il corpo umano come modello geometrico
Il medico greco Galeno fu di grande importanza nella nascita e nello sviluppo dell’anatomia. Medico e filosofo (Pergamo 130 circa – ivi, probabilmente, 200 circa). Dal grande modello della geometria euclidea Galeno trasse la convinzione che ogni edificio di sapere scientifico dovesse venir costruito con lo stesso rigore dimostrativo, giungendo a formulare un progetto di riorganizzazione unitaria, dimostrativamente incontrovertibile, della medicina. Nei suoi studî propriamente medici risultarono decisivi due aspetti: l’anatomia da un lato, l’analisi e il commento dei testi della medicina ippocratica dall’altro. Maestri di Galeno furono Satiro, Pelope, Numisiano, e poi soprattutto gli scienziati legati al Museo di Alessandria, dove egli studiò per cinque anni, e dove venne in contatto con la grande tradizione del commento ippocratico. Le sue idee in ambito medico e anatomico si imposero a tal punto che furono messe in discussione, con cautela, solo a partire da Andrea Vesalio (1514-1564).
Federico II e Bonifacio VIII autorizzano le dissezioni
Dopo il II secolo d. C. l’anatomia verrà abbandonata per oltre dodici secoli. La dissezione dei cadaveri fu vietata dalla Chiesa per molto tempo. Nel XIII secolo si comincia a delineare una situazione nuova. Un’ordinanza dell’imperatore Federico II e un permesso di papa Bonifacio VIII autorizzarono le dissezioni. I medici bolognesi del XIV secolo le praticano in presenza dei loro allievi. Contemporaneamente a partire dal XIII secolo, la scultura e la pittura rappresentarono la figura umana in modo sempre meno schematico. Rivelando quindi un rinnovato interesse per la volumetria dei corpi.
Nel 1302 a Bologna è riportata la prima dissezione pubblica di cadavere a scopo didattico, per opera di Guglielmo da Varignana (1270-1339).

Poco dopo, nel 1315, Mondino de’ Liuzzi (1275-1326) riprende le dissezioni di cadavere come metodo per indagare i misteri dell’anatomia.
La storia dell’anatomia moderna inizia nel Rinascimento, con la pubblicazione, nel 1543, dell’opera dell’anatomico belga Andrea Vesalio. Prima della pubblicazione di questo trattato, gli anatomici basavano le loro conoscenze sugli scritti di scienziati vissuti più di mille anni prima, come quelli del medico greco Galeno, che peraltro si era limitato alla dissezione e all’osservazione di organi animali. Vesalio e altri anatomici del Rinascimento fondarono, invece, le loro opere sull’osservazione diretta di cadaveri, ponendo così le basi dell’anatomia moderna.
Riscoperta dei trattati antichi
E’ l’epoca in cui vengono riletti i trattati antichi, si diffonde nelle scuole la pratica della dissezione. La medicina del Quattrocento, dopo la presa di Costantinopoli (1453) e l’invenzione della stampa (1440), si libera dagli influssi dei trattati arabi e della scolastica medievale, fino ad allora dominanti.
In ambito artistico gli Adamo ed Eva di Van Eyck o di Van der Goes mostrano una nuova cura per i volumi saldamente definiti e delicatamente modellati. Per gli Italiani invece l’anatomia è in primo luogo un problema teorico. I pittori del Quattrocento direttamente implicati in studi anatomici praticano la dissezione e a volte collaborano con i medici. Studiano con passione i modelli antichi. Centro delle ricerche è Firenze e le ricerche più significative sono quelle di Masaccio, Andrea del Castagno, Pollaiolo, Verrocchio, Signorelli. La definizione chiara dei volumi nello spazio va di pari passo con lo studio dei corpi in movimento. Gli affreschi di Signorelli nel duomo di Orvieto restano l’esempio più spettacolare di queste ricerche.
Leonardo da Vinci

Le ricerche anatomiche di Leonardo da Vinci, registrate in numerosi disegni, attestano la curiosità paziente dello scienziato attento a scoprire i meccanismi corporei. Tuttavia i suoi studi ebbero scarse conseguenze. I pittori del Rinascimento preferiscono definire precisi sistemi di misura e di relazioni numeriche tra le varie parti del corpo. Questo perché il concetto stesso di bellezza era legato all’idea di proporzione. La formazione degli artisti si attua, ancor più che sulla dissezione dei cadaveri, attraverso lo studio delle statue antiche.

La rappresentazione visiva del corpo aperto
I testi di medicina nei quali il corpo umano è rappresentato per la prima volta aperto, per mostrarne gli organi, sono il Fasciculus medicinae (Venezia 1491) attribuito a J. Ketham, illustrato con incisioni in legno.


E il Fasciculo di medicina, comprendente l’Anathomia di Mondino de Liucci (1493). In seguito i trattati teorici illustrati si moltiplicano. Liber conciliator di Pietro d’Abano (1496), dove per la prima volta si trovano raffigurazioni di personaggi in parte scorticati. Isogogae breves… in anatomiam humani corporis (1521) di G. Berengario da Carpi. Tabulae anatomicae (Venezia 1538), le cui ricche illustrazioni ebbero grande successo e vennero in parte imitate.
Andrea Vesalio riscrive la descrizione del corpo umano
L’anatomista più celebre fu Vesalio (1514-64). È considerato il fondatore dell’anatomia moderna. Per primo, infatti, pone la questione della necessaria riscrittura della descrizione del corpo umano e delle parti da cui questo è composto a partire dalla pratica della dissezione dei cadaveri e in opposizione alla tradizione antica dominata per secoli dagli scritti anatomici di Galeno e redatti a partire per lo più dalla dissezione e dalla vivisezione di animali.
A partire dal 1533 studia medicina a Parigi sotto la guida dei medici e umanisti Jacques Dubois e Johann Guinther. Tra il 1535 e il 1536 esegue le prime ricerche di osteologia su ossa umane raccolte nei cimiteri e sui patiboli ed esegue le prime dissezioni. Nel 1537 è a Padova dove, il 5 dicembre, consegue il dottorato in medicina nello Studio padovano e dove poco dopo, all’età di 23 anni, viene nominato professore di chirurgia e anatomia.
Nell’Ateneo padovano trascorre sei anni tra insegnamento e ricerca e spesso utilizza, per le dimostrazioni ai suoi studenti, scheletri, ossa e disegni illustrativi. Nel 1538 inizia a lavorare, in collaborazione con vari artisti della scuola di Tiziano per le realizzazione dei disegni, alla sua opera principale il De humani corporis fabrica che termina nel 1542 insieme a Epitome.
Il 1543, anno della pubblicazione del De humani fabrica libri septem corporis (Basilea 1543), può essere considerato uno spartiacque che separa due epoche della medicina: quella medievale da quella moderna. Nell’agosto dello stesso anno termina anche Fabrica (che raccoglie oltre 300 illustrazioni con didascalie) con cui vuole convincere il mondo medico, dell’importanza fondamentale dell’anatomia negli studi medici.
L’illustrazione del trattato, cui hanno probabilmente collaborato J. S. Kalcar, olandese operante a Venezia, e artisti influenzati da Tiziano, è notevole per il suo gusto fantastico, che colloca scorticati in pose teatrali e in mezzo a paesaggi.

I teatri anatomici
Il primo cenno a un teatro anatomico smontabile risale alla fine del Quattrocento e si trova in un volume di Alessandro Benedetti, Anatomice sive de historia corporis humani. Sarà Andrea Vesalio, docente di anatomia e chirurgia a Padova dal 1537 al 1543, a fissarne l’immagine nel monumentale frontespizio della sua opera maggiore, dal titolo De humani corporis fabrica, edita nel 1543. Si tratta probabilmente dello stesso teatro in cui tiene lezione, montato nel cortile antico di palazzo Bo.
Il medico vi esegue personalmente l’autopsia; essa può durare, sullo stesso cadavere, anche una settimana. È assistito dai “massari anatomici”, studenti che si occupano di ottenere i cadaveri dalle autorità e di predisporre il necessario per l’esecuzione dell’anatomia didattica. Si inizia dagli organi addominali, quelli che vanno in putrefazione più velocemente, per concludere con le ossa. E’ cominciata una nuova era.
In Francia l’opera più importante, dopo il trattato di Charles Despars, ricco di reminiscenze gotiche (1500), è il De dissectione humani corporis di Charles Estienne (1540). Le sue incisioni, di tono drammatico, sono caratterizzate dallo stile di Fontainebleau. Va pure menzionato, in Spagna, il trattato di Valverde, illustrato da G. Becerra. A partire dal XVI secolo l’anatomia fa parte del patrimonio comune dell’educazione dei pittori e viene insegnata in tutte le accademie. Furono eseguiti modelli anatomici, in cera, di “scorticati” sin dalla fine del XVI secolo. Baldinucci cita uno “scorticato” smontabile eseguito a Pisa dallo scultore Pierre Francheville nel 1594.

Le seicentesche Lezioni di anatomia

Nel XVII secolo vengono pubblicati accanto ad opere specializzate, trattati semplificati ad uso degli artisti. Come quello di Charles Errard, che unisce esposizioni teoriche all’analisi della bellezza ideale delle statue antiche. Pietro da Cortona e Carlo Cesi pubblicano trattati simili. Nell’Olanda contemporanea l’anatomia quasi non è più altro che un tema per una categoria ben precisa di quadri. Le “lezioni di anatomia” infatti rappresentano un medico che seziona un cadavere dinanzi agli allievi.



L’invenzione, nel XVII secolo, del microscopio composto portò allo sviluppo dell’anatomia microscopica, che viene suddivisa in istologia (studio dei tessuti) e citologia (studio delle cellule). Sempre nel XVII secolo l’anatomico italiano Marcello Malpighi compì le prime osservazioni della struttura microscopica di piante e animali. I più importanti anatomici dell’epoca di Malpighi erano, tuttavia, riluttanti ad accettare l’anatomia microscopica, che oggi costituisce, invece, la base dell’anatomia moderna. Oggi le indagini microscopiche si pongono anche l’obiettivo di identificare il rapporto esistente tra la struttura osservata a occhio nudo e quella fornita dal microscopio.
Settecento illuminista
Nel 1761 Giovanni Morgagni porta a termine la sua voluminosa opera intitolata De Sedibus et Causis per Anatomen Indagatis . Nel testo, il Morgagni riportava i sintomi e le sue osservazioni su circa 700 pazienti con i risultati delle indagini anatomo-patologiche effettuate dopo l’esame dei loro cadaveri. Con questo studio egli ampliava ulteriormente la comprensione sui fatti morbosi implicati nel decesso. Il Morgagni organizzò la sua casistica in base al sistema organico interessato dalla malattia e documentando le storie cliniche dei pazienti, correlandole i risultati delle indagini autoptiche. Molti considerano il De Sedibus come il primo manuale di patologia e Morgagni come il vero padre dell’anatomia patologica.
Così come nel Seicento i medici erano divisi tra jatrochimici (secondo cui l’organismo sarebbe stato una sorta di laboratorio chimico, una fabbrica in cui le diverse funzioni erano esplicate dagli spiriti tramite le virtù insite nei singoli organi) e jatromeccanici (decisamente più sperimentalisti e galileiani, secondo cui il corpo umano è una vera e propria macchina in cui le funzioni si esplicano secondo leggi meccaniche soggette a essere misurate matematicamente), anche nel Settecento in medicina vi sono due concezioni antitetiche: il vitalismo (secondo cui alla base della vita vi sarebbe una forza vitale) e il meccanicismo (secondo cui i fenomeni vitali, caratterizzati da materia e movimento, rispondono alle stesse leggi della fisica).
I principali orientamenti medici sorti specialmente a partire dalla prima metà del Settecento e sui quali si fondarono vere e proprie scuole di pensiero si possono così riassumere:
1. orientamento animistico di G. E. Stahl;
2. orientamento biologico meccanicistico di F. Hoffmann;
3. orientamento vitalistico di J. Brown.
Dalla tendenza verso la sistematica (costruzione di sistemi di pensiero, di dottrina) e dall’influsso del romanticismo nella medicina settecentesca sorgono due grandi sistemi medici:
1. il mesmerismo di F. Mesmer;
2. l’omeopatia di C. F. S. Hahnemann.
In Francia, nel XVII e XVIII secolo l’anatomia costituisce una parte essenziale del tirocinio dell’Academie royale, e negli studi degli artisti si diffondono sculture raffiguranti “scorticati”. Bouchardon realizzò uno di questi modelli. I più celebri restano quelli di Houdon. Scorticato col braccio teso (1767) e Scorticato col braccio alzato (1790). Tra i più riusciti trattati di anatomia del XVIII secolo è il Nouveau Recueil d’ostéologie et de myologie del tolosano Jacques Gamelin (1779), corredato di splendide incisioni.

Anatomia patologica e comparata
L’anatomia patologica era stata fondata, come disciplina scientifica, dal medico italiano Giambattista Morgagni, mentre l’anatomia comparata fu sistematizzata dal naturalista francese Georges Cuvier alla fine del XVIII secolo. Nel XIX secolo, l’anatomia fece rapidamente molti progressi di grande portata, in gran parte grazie ai perfezionamenti ottenuti nel campo della microscopia ottica e dei metodi di fissazione e colorazione delle cellule e dei tessuti. Vennero, inoltre, perfezionati i metodi della microtomia, che consentono il taglio dei tessuti in sezioni estremamente sottili.
Nel 1839 Il primo medico capo del Johns Hopkins Hospital, il Dr. William Osler, contribuisce a fondare la Johns Hopkins School of Medicine. Spesso indicato come il padre della medicina moderna, Osler insisteva sul fatto che gli studenti dovevano visitare e parlare con i pazienti piuttosto che essere confinati nelle aule delle facoltà mediche. È accreditato per aver istituito il primo programma di residenza per la formazione specialistica dei medici. Gran parte della sua conoscenza delle malattie derivava dalle 1.000 autopsie che aveva eseguito nel corso della sua carriera.
L’anatomia è più che mai, nell’Ottocento, la base dell’insegnamento del disegno. I pittori studiano il modello dal vero e le statue antiche con rinnovato impegno. Géricault, disegna dal vero malati in punto di morte nell’ospedale, Beaujon per la sua Zattera della Medusa. Ingres invece trasgredisce l’insegnamento accademico e sfida la realtà anatomica nei suoi nudi audacemente deformati. L’insegnamento nelle scuole d’arte garantì la continuità degli studi di anatomia. La monumentale Anatomie artistique di Richer (1899) servì ancora a generazioni di allievi. Ma la cura dell’esattezza anatomica perse sempre più d’importanza sin dalla fine del XIX secolo.
Anatomia microscopica
Nel corso del XX secolo l’anatomia microscopica ha conosciuto un ulteriore, importante sviluppo grazie all’introduzione di microscopi, dotati di una risoluzione e di un ingrandimento molto superiori agli strumenti convenzionali e, pertanto, in grado di rivelare dettagli prima poco chiari o invisibili. Rispetto al microscopio ottico convenzionale, il microscopio a luce ultravioletta permette, ad esempio, di ottenere un contrasto maggiore, in quanto le lunghezze d’onda di questi raggi sono minori di quelle della luce visibile (il potere di risoluzione di un microscopio è inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda della luce impiegata). Questo tipo di microscopio viene anche utilizzato per sottolineare particolari dettagli, grazie all’assorbimento selettivo, da parte dei tessuti, di determinate lunghezze d’onda presenti nell’ultravioletto. L’invenzione del microscopio elettronico, che rispetto al microscopio ottico raggiunge un potere di risoluzione e livelli d’ingrandimento enormemente superiori, ha consentito di esplorare strutture subcellulari prima intoccabili dall’indagine anatomica. Altri microscopi moderni, come il microscopio a contrasto di fase e il microscopio interferenziale, hanno permesso di osservare materiali viventi privi di colorazione artificiale, i quali sarebbero risultati invisibili al microscopio convenzionale.
L’istochimica e la citochimica, due tecniche strettamente collegate, permettono di compiere indagini sulle attività chimiche dei tessuti e delle cellule; ad esempio, la presenza di determinati colori all’interno delle cellule può indicare che si sono verificate particolari reazioni chimiche. Inoltre, l’intensità del colore può essere un indice della forza della reazione. I metodi istochimici sono stati particolarmente utili per lo studio delle attività enzimatiche che catalizzano le reazioni di cellule e tessuti. In realtà, la maggior parte delle conoscenze sugli enzimi sono state acquisite in studi condotti dopo aver estratto e purificato queste molecole dalle cellule di origine. L’avvento dell’istochimica ha consentito agli anatomici di arricchire queste conoscenze, osservando direttamente al microscopio la presenza di una particolare attività enzimatica in un determinato tessuto.
Virtopsy
Nei primi anni ’90 con lo sviluppo della tecnologia, nasce l’idea di poter documentare in modo non invasivo le patologie organiche. Si pensa, all’utilizzo di TAC, risonanza magnetica e scansioni 3D. Il professore svizzero Richard Dirhofer coniò, per questo tipo di accertamenti, il termine “Virtopsy“.
Antonio De Lisa
Diritti riservati
Categorie:D10.05- [SEMIOTICA DEL CORPO UMANO]
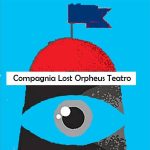

Lascia un commento